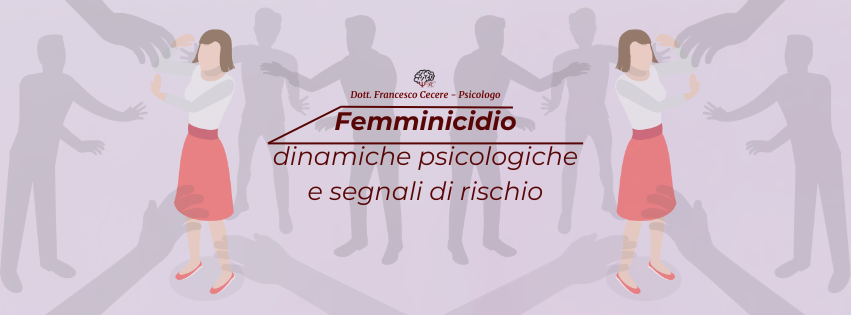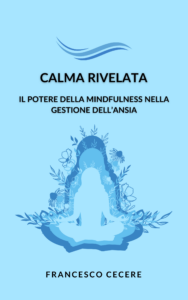Il termine femminicidio non rappresenta soltanto l’uccisione di una donna, ma è un atto estremo di violenza radicato all’interno di una relazione di potere, controllo e sopraffazione.
È il tragico epilogo di una spirale di dinamiche disfunzionali che spesso si sviluppano nel silenzio e nell’invisibilità quotidiana.
Come psicologo, credo sia fondamentale analizzare non solo il fenomeno nella sua gravità, ma anche le dinamiche psicologiche sottostanti, per promuovere una reale cultura della prevenzione.
Che cos’è il femminicidio?
Il femminicidio si configura come l’uccisione di una donna – da parte di un uomo – in quanto tale. Parliamo quindi di un omicidio legato a motivi di genere, ed è frequentemente l’atto conclusivo di un percorso di violenza domestica, fisica, psicologica, economica o sessuale.
Non si tratta di un omicidio “qualsiasi”: il femminicidio si colloca in una cornice relazionale in cui la donna viene percepita come oggetto di possesso, privo di autonomia.
È importante sottolineare che non tutti i casi di omicidio di una donna sono automaticamente femminicidi: ciò che distingue questo fenomeno è la matrice di genere e la volontà di esercitare potere, dominio e controllo.
Dinamiche psicologiche alla base del femminicidio
Dietro ogni femminicidio si celano processi psicologici complessi, che coinvolgono sia la vittima che l’autore della violenza. Tra le dinamiche più frequenti troviamo:
Possessività e controllo
L’autore del femminicidio vive spesso la relazione come un’estensione di sé, in cui l’altro non è riconosciuto come persona autonoma ma come proprietà personale.
La perdita o la minaccia di perdita (separazione, emancipazione della partner) può essere percepita come una ferita narcisistica insopportabile, una ferita per cui l’autore di violenza vive una forte umiliazione.
Dipendenza affettiva e incapacità di elaborare la separazione
Molti soggetti che agiscono violenza estrema presentano una dipendenza affettiva patologica, che si traduce nell’incapacità di tollerare la frustrazione derivante dall’abbandono o dal rifiuto.
La separazione viene vissuta come un annientamento personale, che può sfociare in comportamenti autodistruttivi o eterodistruttivi.
Disturbi di personalità e disregolazione emotiva
In alcuni casi, alla base del comportamento violento si riscontrano tratti di personalità disfunzionali o dei franchi disturbi di personalità, in particolare:
- Disturbi borderline
- Disturbi narcisistici
- Disturbi antisociali
Questi profili sono accomunati da una scarsa capacità di gestione delle emozioni intense e da una visione distorta delle relazioni interpersonali.
Modelli di apprendimento violento
Chi ha vissuto durante l’infanzia esperienze di violenza domestica o genitoriale è più a rischio di sviluppare modelli relazionali violenti, riproponendo nella propria vita adulta dinamiche apprese come “normali”.
Segnali di rischio: cosa osservare
Il femminicidio non avviene quasi mai in modo improvviso. Spesso è preceduto da segnali che, se colti per tempo, possono attivare efficacemente interventi di protezione.
Tra i principali campanelli d’allarme:
- Controllo ossessivo: gestione degli spostamenti, delle amicizie, dei contatti sociali.
- Isolamento: progressiva limitazione delle relazioni familiari e amicali della vittima.
- Minacce, anche velate: frasi come “senza di me non puoi vivere”, “se mi lasci ti rovino” non devono mai essere sottovalutate.
- Comportamenti di stalking: pedinamenti, sorveglianza continua, invio di messaggi minacciosi.
- Agiti di violenza fisica: anche minimi, che tendono a intensificarsi nel tempo.
- Espressioni di disperazione estrema: tentativi di suicidio strumentali o dichiarazioni di morte congiunta (“se te ne vai, moriamo insieme”).
La presenza anche di uno solo di questi elementi deve indurre a prendere seriamente la situazione.
La prevenzione: una responsabilità collettiva
La prevenzione del femminicidio non può basarsi esclusivamente sull’intervento delle forze dell’ordine o degli operatori sanitari.
È necessario un cambiamento culturale profondo che parta dalla società intera, attraverso:
- Educazione all’affettività e al rispetto fin dalla scuola primaria.
- Formazione degli operatori che entrano in contatto con le vittime.
- Potenziamento dei servizi di supporto psicologico accessibili e capillari.
- Trattamento degli uomini autori di violenza, con programmi psicologici specifici (come quelli che effettuiamo al CUMM di Taranto).
- Sensibilizzazione dell’opinione pubblica, per abbattere stereotipi e bias.
Il ruolo dello psicologo clinico e forense
Il mio lavoro di psicologo clinico e giuridico-forense mi pone ogni giorno davanti alla complessità delle relazioni violente. In questi contesti, il supporto psicologico ha molteplici funzioni:
- Supportare la vittima nella ricostruzione della propria autostima e nella gestione del trauma.
- Valutare il rischio di recidiva nei soggetti autori di violenza.
- Fornire consulenze tecniche (CTU e CTP) nei procedimenti civili e penali.
- Promuovere programmi di prevenzione basati sull’educazione emotiva e relazionale.
Lo psicologo non è soltanto colui che interviene “dopo”, ma deve essere parte attiva nel riconoscere, segnalare e prevenire.
Il femminicidio è il risultato di dinamiche psicologiche, culturali e sociali che devono essere comprese a fondo per essere contrastate. Non possiamo più permetterci di considerarlo una “tragedia imprevedibile”: i segnali esistono, e saperli riconoscere è il primo passo verso la tutela della vita e della dignità delle donne.
Se vivi o conosci qualcuno che vive una situazione di violenza, non rimanere in silenzio. Il supporto può fare la differenza.
👉
Seguimi sui social